



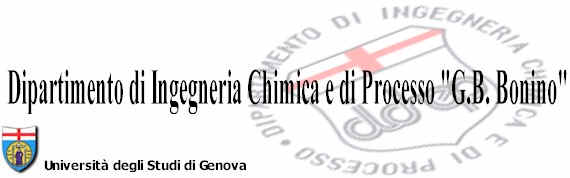
![]() Politiche
Integrate di Prodotto
Politiche
Integrate di Prodotto
![]() Difficoltà
e benefici dell'LCA
Difficoltà
e benefici dell'LCA
![]() Report
ambientali
Report
ambientali
FASI DI UN LCA
L’elaborazione di un LCA si articola essenzialmente in quattro fasi:
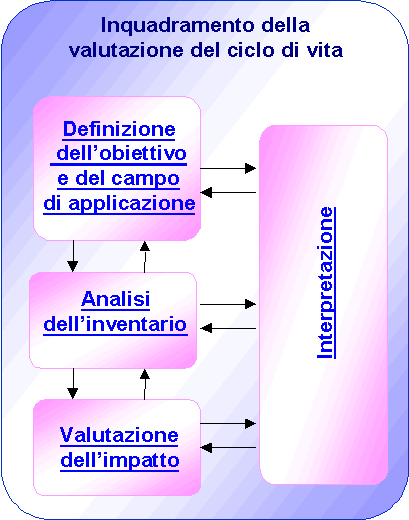
Fasi di un LCA
1.
DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il
primo passo è la definizione dell’Unità Funzionale, cioè il prodotto,
il servizio o la funzione su cui impostare l’analisi e il confronto con
le possibili alternative (kg di prodotto, t di rifiuto trattato, Kwh di
energia fornita…..).
L'unità
funzionale indica l'oggetto riferimento del nostro studio a cui tutti
i dati in ingresso ed in uscita saranno normalizzati.
È così definita dalla ISO 14040:
-
Misura della prestazione del flusso in uscita funzionale del sistema prodotto.
-
Lo scopo principale dell’unità funzionale è di fornire un riferimento a cui legare i flussi in uscita ed in entrata.
È
un riferimento necessario per consentire la comparabilità dei risultati
dell’LCA. Utile quando si valutano sistemi differenti, si deve assicurare
che il confronto venga fatto su base comune.
Sempre
in questa fase saranno definite:
-
Scopi del LCA (che cosa si vuol conoscere?).
-
Il livello di dettaglio che si vuole ottenere nello studio.
-
Affidabilità delle informazioni richieste nello studio.
1.1
Scopi di un LCA
In
questo modulo si definiscono i tipi di problemi ai quali si vuole rispondere:
-
Confrontare tra loro due prodotti, oppure confrontare l’oggetto dello studio con uno standard di riferimento.
-
Pianificare dei miglioramenti ad un prodotto già esistente oppure progettare un nuovo prodotto.
1.2
Livello Di Dettaglio
Il livello di dettaglio dell’analisi dipende dal tipo d’utente per il quale è eseguita l’analisi: se lo studio è fatto per uso interno all’azienda (migliorare le performance ambientali del prodotto) si può produrre un LCA SEMPLIFICATO, nel quale si considerano solo gli aspetti critici per il soggetto che produce il LCA, viceversa se lo studio è condotto per uso esterno (ad esempio per relazionare la politica ambientale del legislatore) è necessario fare un’elaborazione più completa
.
1.3
Affidabilità Delle Informazioni Richieste Nello Studio
In
questa fase non si hanno a disposizione spesso dati precisi e occorre
quindi fare riferimento alla letteratura già esistente.
L’inventario
consiste nella descrizione quantitativa di tutti i flussi di materiali
ed energia che attraversano i confini del sistema sia in ingresso sia
in uscita.
Il
risultato dell’inventario è la stesura di una TABELLA D’INVENTARIO che
mostra tutti gli usi delle risorse, le emissioni associate all’unità funzionale,
comprese, ad esempio, tutte le sostanze e i composti chimici utilizzati.
Per
descrivere tali flussi, il LCA, utilizza i due principi fondamentali della
fisica:
-
Principio di conservazione della massa.
-
Principio di conservazione dell’energia.
L’inventario
è costituito da cinque parti:
-
Confini del sistema (SYSTEM BOUNDARIES).
-
Diagramma di flusso (PROCESS FLOWCHART).
-
Raccolta dei dati (COLLECTION OF DATA).
-
Regole/problemi di allocazione degli impatti (ALLOCATION PROCEDURES).
-
Elaborazione dei dati (PROCESSING DATA).
2.1
Confini Del Sistema
È
in questa fase che si definisce più nel dettaglio il sistema:
-
descrizione qualitativa e quantitativa delle unità di processo;
-
categorie di dati ad esse associate;
-
ipotesi e assunzioni (trascurare alcuni ingressi ed uscite).
Inizialmente ci si concentra sul processo di manifattura, cercando di individuare i passi ilevanti e i flussi di materiali ed energia, nonché le emissioni nell’ambiente.
Successivamente
si estende l’analisi a monte ed a valle del processo manifatturiero, considerando
l’estrazione della materia prima, i trasporti prima e dopo il ciclo produttivo,
l’uso dei prodotti, il riciclaggio e lo smaltimento.
Prima
di costruire nel dettaglio il diagramma di flusso e di procedere con la
raccolta dati è bene specificare alcune informazioni riguardanti le unità
di misura utilizzate, la loro definizione e i procedimenti per la raccolta
dei dati. Al fine di assistere il personale addetto a questa fase, occorre
descrivere le tecniche di raccolta dati, che possono variare a seconda
delle unità di processo e a seconda della composizione e qualificazione
di coloro che partecipano allo studio.
2.2
Diagramma Di Flusso
Nel
PROCESS FLOWCHART si rappresentano le componenti di un sistema che è composto
da sequenze di processi (boxes) collegati da flussi di materiali (frecce).
Lo
schema più rappresentativo, valido per la maggior parte dei sistemi industriali,
ha come scopo l’individuazione dei maggiori processi e interventi ambientali
e può essere diviso in sette sequenze:
-
Produzione principale.
-
Produzione secondaria o co-prodotto.
-
Produzione dei materiali ausiliari.
-
Produzione d’energia.
-
Consumo d’energia.
-
Trasporti.
-
Trattamento rifiuti.
Produzione
principale
Questa
sequenza evidenzia il processo di produzione prioritario del prodotto.
In
questa fase sono evidenziati i principali passi di processo e i maggiori
flussi di materiali.
Produzione
secondaria o co-prodotto
Tale sequenza riguarda il processo di fabbricazione del prodotto che è realizzato durante la produzione del prodotto principale.
Produzione
dei materiali ausiliari
Questa
fase ha lo scopo di estendere il process flowchart coi processi che appaiono
prima, durante e dopo la fabbricazione del prodotto.
Ciò
consentirà di analizzare l’estrazione, la produzione e i componenti delle
materie prime, dall’altro mostrerà l’uso del prodotto, i consumi, il riciclaggio
o riuso e i processi della gestione dei rifiuti.
Produzione
d’energia
Questa
sequenza riguarda la possibilità di recuperare energia sotto forma di
calore o elettricità.
Consumo
d’energia
Questa
sequenza prende in considerazione i consumi d’energia dovuti ai vari processi.
Trasporti
Questa
sequenza riguarda i mezzi di trasporto usati per il trasporto del prodotto
o coprodotto, ma soprattutto interessa la quantità di prodotto trasportato
per chilometro.
Trattamento
dei rifiuti
Considera
i trattamenti che sono applicati agli scarti di lavorazione e ai materiali
ausiliari.
2.3
Raccolta Dei Dati
Una
volta che si è schematizzato il processo si passa alla fase di raccolta
dei dati. Questi saranno di due tipi: quelli relativi ai flussi d’ingresso
(input) e quelli corrispondenti alle uscite (output).
I primi si riferiscono a materiali, trasporti ed energia, gli altri ai prodotti e ai gas rilasciati in aria, acqua e suolo. Lo scopo sarà quello di strutturare un vero e proprio bilancio ambientale per la redazione del quale dovrà essere controllata la qualità dei dati.
Questa
deve essere valutata sulla base dei seguenti parametri:
-
Età dei dati.
-
Tecnologia di riferimento.
-
Processo al quale è riferito il dato.
-
Metodi di calcolo impiegati per ottenere valori medi.
-
Varianza e irregolarità riscontrate nella misurazione.
Potrebbe
allora essere costruita una sorta di matrice per definire e valutare con
un discreto grado d’approssimazione il livello qualitativo dei dati impiegati
per avviare un LCA.
I
dati raccolti possono essere distinti in tre categorie:
-
Dati primari (provenienti da rilevamenti diretti).
-
Dati secondari (ricavati dalla letteratura).
-
Dati terziari (provenienti da stime e valori medi).
2.4
Regole/problemi di allocazione degli impatti.
La
maggior parte dei processi industriali ha più di un prodotto e ricicla
i prodotti intermedi o di scarto come fossero materie prime. I flussi
di materia ed energia devono essere allocati ai differenti prodotti secondo
procedure chiaramente definite.
"Allocazione:
ripartizione nel sistema di prodotto allo studio dei flussi in entrata
e in uscita di unità di processo"
Lo
studio di LCA deve identificare processi condivisi e trattarli con procedure
specifiche. La somma dei flussi allocati in ingresso e in uscita da un’unità
di processo deve essere uguale ai flussi in ingresso e in uscita non allocati
dell’unità di processo
Come
risolvere i problemi di allocazione:
Fase
1: ove possibile si dovrebbe evitare l’allocazione mediante:
Divisione unità di processo da allocare in due o più sottoprocessi
Espansione del sistema di prodotti per includere funzioni aggiuntive relative
ai co-prodotti
Fase 2: dove l’allocazione non è evitabile, si devono impiegare relazioni fisiche chiare (in base alla
massa, al volume,...)
Fase 3: se le relazione fisiche non sono chiare usare altre relazioni, per esempio il valore economico dei co-prodotti.
2.5
Elaborazione Dei Dati
In
questa parte dell’inventario i dati raccolti relativi al ciclo produttivo
sono trasformati in una tabella d’impatti ambientali causati dall’unità
funzionale in studio, la TABELLA DELL’INVENTARIO.
Per far ciò si deve disporre di due tipi di dati:
-
Dati relativi ad ogni processo necessario alla produzione del prodotto (esempio: quantità d’energia elettrica utilizzata nella produzione, quantità di materie prime necessaria....), disponibili presso l’azienda.
-
Dati riguardanti l’impatto ambientale del prodotto ottenuto con il processo considerato.
Questi dati devono successivamente essere riferiti all’unità funzionale scelta.
In
questa fase si fa spesso uso di software dedicati:
-
Mettono a disposizione una serie di processi già implementati e permettono anche di inserirne di nuovi.
-
Presenza di database relativi a varie categorie: materiali, combustibili e sistemi di trasporti, a cui si aggiungono anche i sistemi di smaltimento dei rifiuti.
-
I risultati sono presentati con tabelle di inventario in cui sono raccolti tutti i dati relativi ai flussi di input e di output
Tale
valutazione è un processo tecnico-quantitativo e/o qualitativo per valutare
gli effetti degli impatti ambientali delle sostanze identificate nell’inventario.
Per
impatto ambientale s’intende l’intervento di una sostanza sull’ambiente
e/o sull’uomo.
Le
fasi principali di questo modulo sono:
-
Classificazione.
-
Caratterizzazione.
-
Normalizzazione.
-
Pesatura.
Le
uniche fasi obbligatorie ai sensi della norma ISO 14040 sono quelle di
Classificazione e Caratterizzazione.

Valutazione degli impatti
3.1
Classificazione
È
la fase nella quali i dati dell’inventario sono suddivisi in temi o categorie
d’impatti ambientali.
Queste
categorie d’impatto ambientale sono riconducibili a tre grandi aree di
protezione ambientale:
-
Esaurimento delle risorse.
-
Salute umana .
-
Conservazione dell’ambiente.
Nelle
quali possiamo ricondurre i seguenti temi ambientali:
-
Potenziale impoverimento delle materie prime.
-
Potenziale impoverimento delle fonti energetiche.
-
Potenziale riscaldamento globale (effetto serra). (GWP: Global Warming Potential).
-
Potenziale impoverimento dello strato d’ozono. (ODP: Ozone Depletion Potential).
-
Ecotossicità delle acque e del suolo.
-
Acidificazione potenziale. (AP: Acidification Potential).
-
Tossicità per l’uomo.
-
Eutrofizzazione. (NP: Nutrification Potential).
3.2
Caratterizzazione
Questa
fase è immediatamente successiva alla classificazione ed ha lo scopo di
quantificarla.
Suo compito è quello di quantificare gli impatti ambientali della tabella d’inventario all’interno delle categorie d’impatto ambientale. Quest’operazione è effettuata per mezzo di una classificazione di fattori di peso (weight factors) stabiliti da una Autority. Tali fattori rappresentano il contributo degli stressors alle categorie d’impatto e sono basati su alcuni criteri, i quali hanno lo scopo di definire una soglia limite per ogni tema ambientale.
Le
tabelle di seguito riportate sono quelle generalmente impiegate dai ricercatori
nel campo LCA e sono state redatte da gruppi di studio afferenti alle
Nazioni Unite.
(Rif:
Wenzel,H., Hauschild,M., Alting,L.
“Environmental Assessment of Products”, Chapman & Hall, 1997).
Energia
Primaria
Questo indicatore considera la richiesta di energia primaria per l'intero ciclo di vita del prodotto considerato, tenendo conto ad esempio della trasformazione dei materiali combustibili in energia elettrica.
A questo indicatore contribuiscono quindi i materiali combustibili con il loro contenuto di energia primaria.
Il fattore di caratterizzazione è in questo caso il potere calorifico del materiale considerato.
Effetto serra
L'indicatore effetto serra viene calcolato considerando, tra le sostanze emesse in aria, quelle che contribuiscono al potenziale riscaldamento globale del pianeta terra.
La quantità in massa di ciascuna sostanza, calcolata sull'intero ciclo di vita del prodotto, viene moltiplicata per un coefficiente di peso, chiamato potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential). Sommando poi i contributi delle varie sostanze si ottiene il valore aggregato dell'indicatore.
Le sostanze che contribuiscono all'effetto serra sono principalmente: CO2, CH4, N2O, CFC, gli HCFC e gli HFC.
La CO2 è la sostanza di riferimento per questo indicatore, vale a dire che il suo coefficiente di peso è uguale a 1 e i valori dell'indicatore sono espressi in kg di CO2 equivalente (kg CO2 eq).
| Composto |
Formula |
GWP100 [kg
CO2/kg gas] |
|
Diossido
di carbonio |
CO2 |
1 |
|
Ossido
di carbonio |
CO |
2 |
|
Metano
|
CH4 |
11 |
|
Ossido
di azoto |
N2O |
320 |
|
CFC-11 |
CFCl3 |
4.000 |
|
CFC-12 |
CF2Cl2 |
8.500 |
| Clorotrifluorometano
(CFC-13) |
CF3Cl |
11.700 |
| Tetrafluorometano
(CFC-14) |
CF4 |
9.300 |
| HCFC-22 |
CHF2Cl |
1.700 |
|
HCFC-125 |
CHF2CF3 |
3400 |
|
Halon-1301 |
CF3Br |
5.600 |
|
Diclorometano |
CH2Cl2 |
25 |
|
Cloroformio |
CHCl3 |
15 |
Fattori di standardizzazione per i principali responsabili dell’effetto serra basati sul loro diretto contributo al riscaldamento globale con un tempo-orizzonte di 100 anni
Assottigliamento
della fascia di ozono stratosferico
La
riduzione della fascia di ozono stratosferico si calcola come l'indicatore
precedente, ma facendo riferimento a diverse sostanze (CFC, HCFC) e con
un diverso coefficiente di peso, chiamato potenziale di riduzione dell'ozono
(ODP, Ozone Depletion Potential).
La sostanza presa come riferimento è in questo caso un cloro - fluoro - carburo e precisamente il CFC - 11.
| Composto |
Formula |
ODP
[g CFC11/g composto] |
|
CFC-11 |
CFCl3 |
1 |
|
CFC-12 |
CF2Cl2 |
0,82 |
|
CFC-113 |
C2F3Cl3 |
1,07 |
|
CFC-114 |
C2F4Cl2 |
0,90 |
|
CFC-115 |
C2F5Cl |
0,85 |
|
HCFC-22 |
CHF2Cl |
0,04 |
|
HCFC-123 |
CHCl2CF-3 |
0,014 |
|
Halon-1301 |
CF3Br |
12,00 |
|
Halon-1211 |
CF2BrCl |
5,1 |
|
Halon-2402 |
C2F4Br2 |
7,00 |
|
HC-10 |
CCl4 |
1,08 |
Fattori di standardizzazione dei principali responsabili dell’assottigliamento della fascia di ozono stratosferico, basati sul loro contributo fino al raggiungimento dell’equilibrio
Acidificazione
L'indicatore
di acidificazione è legato alle emissioni in aria di particolari sostanze
acidificanti, quali ossidi di azoto e ossidi di zolfo.
La
sostanza di riferimento è la SO2 ed il coefficiente di peso
prende il nome di potenziale di acidificazione (AP, Acidification Potential).
| Formula |
AP
[kg SO2/kg composto] |
|
SO2 |
1 |
|
SO3 |
0,80 |
|
S |
2,00 |
|
H2SO4 |
0,65 |
|
H2S |
1,88 |
|
NO2 |
0,70 |
|
NOx |
0,70 |
|
NO |
1,07 |
|
NH3 |
1,88 |
|
HCl |
0,88 |
|
HNO3 |
0,51 |
|
H3PO4 |
0,98 |
|
HF |
1,60 |
|
HCN |
1,19 |
Fattori
di standardizzazione per i principali responsabili dell’acidificazione.
Eutrofizzazione
Questo
indicatore valuta l'effetto di eutrofizzazione, vale a dire l'aumento
della concentrazione delle sostanze nutritive in ambienti acquatici. Le
sostanze che concorrono al fenomeno dell'eutrofizzazione sono i composti
a base di fosforo e di azoto.
La sostanza di riferimento è il fosfato (PO4) ed il coefficiente di peso prende il nome di potenziale di nutrificazione (NP, Nutrification Potential).
| Formula |
NEP
[kg NO3-/kg composto] |
|
NO3- |
1 |
|
NO2 |
1,35 |
|
NOx |
1,35 |
|
NO |
2,07 |
|
N2O |
2,82 |
|
NH3 |
3,64 |
|
HCN |
2,29 |
|
N |
4,43 |
|
PO4--- |
10,45 |
|
P |
32,03 |
Formazione
di smog fotochimico (photo-smog)
Sotto
il nome di smog estivo vengono raggruppate tutte quelle sostanze organiche
volatili che portano alla formazione fotochimica (in presenza di radiazione
solare) di ozono troposferico.
Il
fattore di caratterizzazione è chiamato potenziale di formazione di ozono
fotochimico (POCP, Photochemical Ozone Creation Potential) e la sostanza
di riferimento è l'etilene (C2H4).
| Composto |
POCP
[g C2H4/g di composto] |
|
metano |
0,007 |
|
etano |
0,100 |
|
propano |
0,500 |
|
aldeidi |
0,3±0,2 |
|
CO |
0,040 |
|
metanolo |
0,123 |
|
etanolo |
0,268 |
Fattori
di standardizzazione per i principali responsabili dello smog fotochimico.
Rifiuti
Solidi
L'indicatore in questione raggruppa tutti i rifiuti di tipo solido che vengono generati in una qualsiasi attività nel ciclo di vita di un prodotto, come ad esempio durante la generazione di energia elettrica necessaria per una data lavorazione, oppure durante la produzione delle lamiere di acciaio.
Non esistono per questo indicatore dei fattori di caratterizzazione ed ogni sostanza viene sommata alle altre semplicemente tenendo conto della quantità emessa in massa.
3.3
Normalizzazione
Molti
metodi permettono ai risultati delle categorie di impatto di essere confrontati
con un valore di riferimento.
Ciò
significa che la categoria di impatto è divisa a seconda del riferimento.
Questo può essere scelto a seconda dei casi, ma in generale si adotta il carico medio annuale, in una nazione o in un continente, diviso per il numero degli abitanti.
Il
metodo da noi scelto per questa fase è il metodo pubblicato da CML, Università
di Leiden nell’Ottobre 1992.
Il
primo e probabilmente più diffuso manuale di normalizzazione, fu pubblicato
nel 1993 da CML.
Questo
manuale fu pubblicato estrapolando i dati dal Registro Olandese per le
Emissioni.
La
maggior parte dei fattori era semplicemente moltiplicata per 100, per
poterli rapportare a livello mondiale, essendo il contributo dell’Olanda
al Gross National Product, solo dell’1%.
Un
eccezione fu fatta per i cambiamenti climatici e per l’impoverimento dello
strato di ozono.
Questi
fattori furono direttamente presi dall’IPCC, e si suppone che riflettano
le emissioni mondiali.
Al
fine di rendere tali fattori più gestibili, sono stati divisi per la popolazione
mondiale (circa 6.000.000.000).
Un
recente progetto a cura di IVAM-ER e PRè, sotto la tutela di VROM e RIZA,
in Olanda è stato pubblicato sotto forma di tre nuovi manuali di fattori
di normalizzazione.
Essi
sono per la maggior parte basati sul registro delle emissioni (anno 1994)
e su alcune altre fonti.
I
livelli di normalizzazione sono:
-
Territorio olandese: tutte le emissioni emesse in Olanda e tutti i tipi di materie prime usate.
-
Consumatore olandese: sono stati aggiunti gli effetti dovuti alle importazioni e sono stati levati quelli dovuti alle esportazioni.
-
Territorio europeo (CE, Svizzera, Austria e Norvegia): La maggior parte dei dati sono quelli originali europei (in parte estrapolati da quelli svizzeri e olandesi). Il consumo di energia in una regione era stato preso come base per l’estrapolazione.
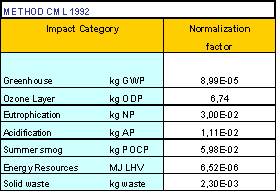
Esempio
di fattori di normalizzazione. Centre
for Environmental Studies (CML), University of Leiden, 1992.
3.4
Pesatura
Alcuni
metodi permettono la pesatura tra diverse categorie d’impatto.
Ciò
significa che i risultati delle categorie d’impatto sono moltiplicati
per dei fattori di peso, e sono fra loro addizionati per ottenere un valore
globale.
4.
VALUTAZIONE DEI MIGLIORAMENTI
È
la fase nella quale sono valutate e selezionate le opzioni per ridurre
gli impatti e i carichi ambientali dell’unità funzionale in studio.
Essa
consente, ove possibile, un miglioramento dell’impatto ambientale in temi
quali ad es. minor richiesta d’energia, minori emissioni, minor uso di
risorse, ecc.
In
questo modulo bisogna unire ai risultati tecnico-ambientali forniti dalla
LCA tutte le altre informazioni riguardanti, il prodotto in studio; informazioni
di carattere economico-finanziario e politico-sociale sul prodotto e informazioni
sulla ricettività-soddisfazione dei consumatori e sul consenso dell’opinione
pubblica, al fine di trovare un prodotto eco-compatibile o, in altre parole,
al fine di prendere una corretta decisione circa la politica di prodotto
aziendale e i programmi ambientali che l’azienda intende sviluppare in
futuro.
È
importante sottolineare che il LCA, come tutte le metodologie basate sul
confronto, non propone una soluzione assoluta, ma identifica un insieme
d’alternative tra le quali poi chi dovrà decidere sceglierà a suo giudizio
la migliore.
Gli obiettivi di questa fase sono i seguenti:
-
Traduzione ed interpretazione dei risultati.
-
Verifica dell’ottenimento degli obiettivi dello studio (iterazione), della qualità dei dati e dei limiti del sistema (analisi di sensitività)
-
Paragonare le possibili opzioni.
I
risultati vanno interpretati e rappresentati in modo da avere una percezione
dei risultati che sia facilmente fruibile, cercando anche di rappresentare
scenari diversi da quello considerato (tipiche sono le rappresentazioni
mediante grafici a barre ed a torta).
L’ANALISI
DI SENSITIVITÀ dovrà verificare l’accuratezza dei dati e la loro influenza
sul risultato finale, mentre un parere da persone esperte è consigliabile
per evitare conclusioni poco attendibili. Per rappresentare la variabilità
dei dati, si può inizialmente pensare di fare un confronto tra i risultati
ottenuti e quelli relativi alla situazione migliore ed a quella peggiore;
un'analisi più complessa richiederebbe lo studio dell’intervallo di variabilità
dei dati in ingresso.